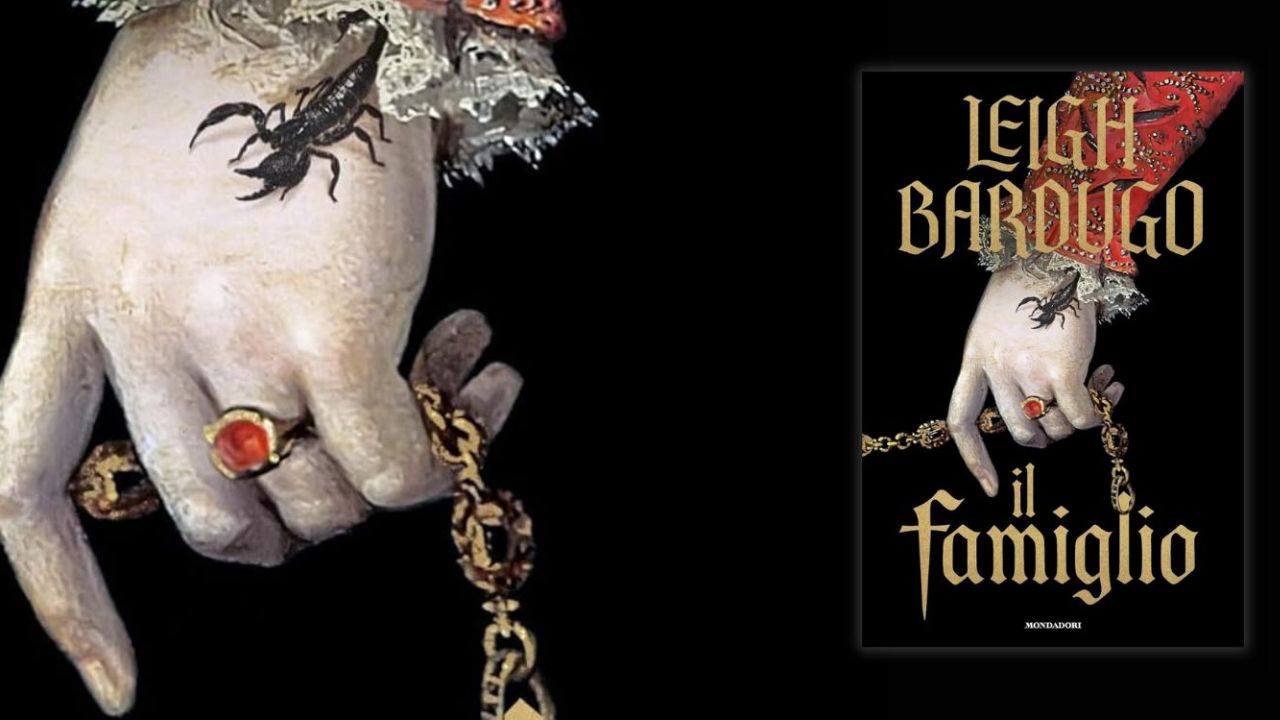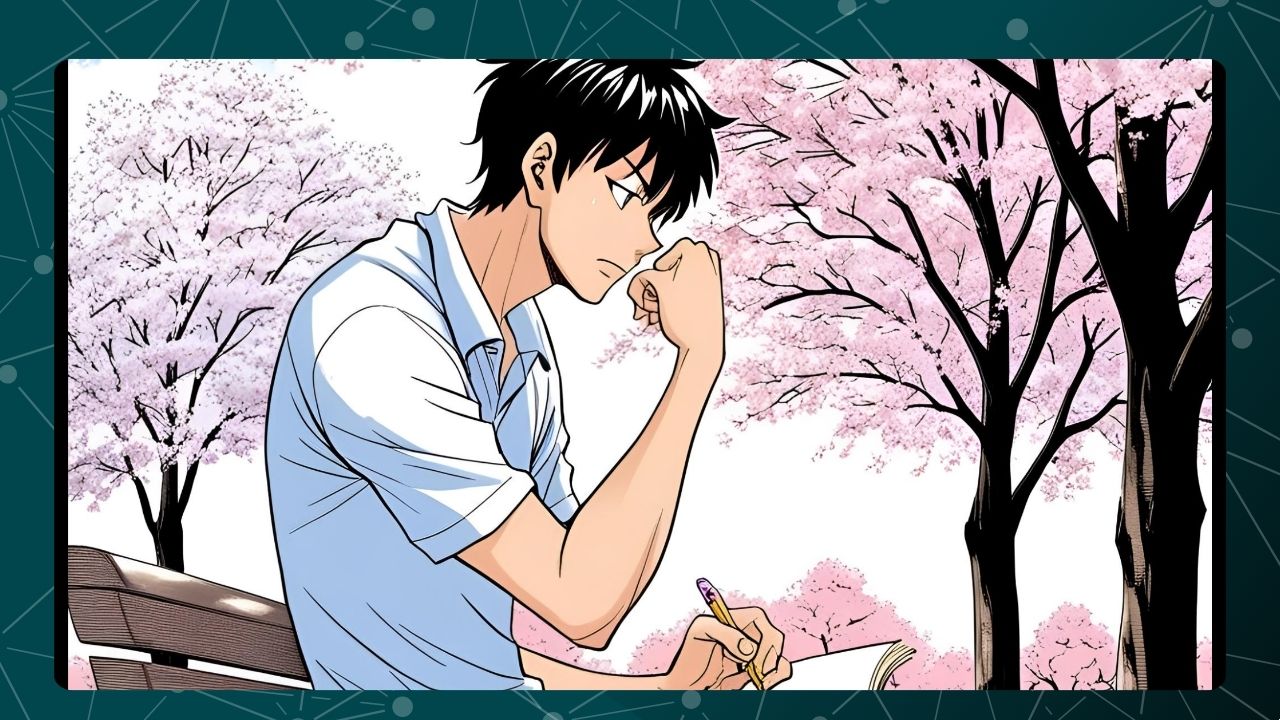Quando ho deciso di parlare di compassione, la prima cosa che ho fatto è stata quella che facciamo spesso quando qualcosa ci incuriosisce: sono andato a cercare il significato della parola.
E lì, in quell’etimologia, ho trovato la prima chiave.
“Compassione” viene dal latino cum patior, “soffrire con”.
E già qui c’è tutto.
Non significa compatire dall’alto. Non significa guardare qualcuno dall’esterno, col binocolo dell’indifferenza o della pietà.
Significa essere dentro. Sentire insieme. Con-dividere la sofferenza. Starci, non fuggire. Restare accanto.
La compassione è questo: esserci.
Nel mondo frenetico di oggi, dove ogni dolore viene silenziato, dove tutto deve essere veloce, efficiente, funzionale… avere compassione è quasi un atto rivoluzionario.
Perché la compassione rallenta.
Ti obbliga a guardare. A fermarti. A sentire.
E ti costringe, senza dire una parola, a fare qualcosa che non è più tanto scontato: riconoscere l’altro.
Mi sono chiesto: ma dov’è finita, oggi, la compassione?
Nei luoghi di lavoro? Dove tutto è KPI, performance, obiettivi, fatturato? Dove si chiedono risultati, ma non si ascoltano le persone?
Nella società? Dove chi sbaglia viene messo al muro, deriso, giudicato?
Nelle nostre case? Dove si vive insieme, ma ognuno è chiuso nel suo schermo, nel suo algoritmo personale?
E allora ho pensato che la compassione non è qualcosa da imparare, ma da ricordare.
È una memoria del cuore. È come un software già installato in noi, ma che abbiamo smesso di aggiornare.
Essere compassionevoli non vuol dire “essere buoni”. Vuol dire essere veri.
Ti è mai capitato di vedere qualcuno piangere, e sentire che stavi piangendo anche tu, dentro?
Di ascoltare una storia dolorosa e non riuscire più a togliertela dalla testa?
Di guardare qualcuno cadere… e invece di dire “è colpa sua”, pensare: “potrei essere io”?
Quella è compassione. Non te la insegna nessuno. Ti attraversa. Ti sveglia. Ti mette in contatto con la parte più fragile e più umana che c’è in te.
Immaginate una donna, stanca, provata. Il padre malato, il lavoro che non ingrana, due figli piccoli che reclamano tutto il suo tempo. Una di quelle giornate in cui il mondo sembra pesare troppo, e ogni parola detta suona come un’altra cosa da sopportare.
Di fronte a lei, c’è un amico. La ascolta. La guarda. E si rende conto che qualunque cosa possa dire… non servirà.
Nessun consiglio. Nessuna frase motivazionale. Nessun “vedrai che passa”.
Allora fa qualcosa di apparentemente piccolo.
Sta zitto.
Rimane. In silenzio.
Le prende la mano. E basta.
In quel gesto semplice, c’è tutto: la presenza, l’empatia, la condivisione. Non sta cercando di salvarla. Non sta cercando di aggiustare nulla.
Sta solo stando. Con lei. Nel dolore. Nel vuoto. Nella fatica.
Quello, forse, è il momento in cui nasce la vera compassione.
Non quando cerchiamo di spiegare. Ma quando scegliamo di restare.
Forse la compassione è proprio questo: lasciare che l’altro sia, anche nel dolore.
Non voler sistemare tutto. Non voler avere sempre la soluzione pronta.
Ma accogliere. Rimanere. Non scappare.
E allora sì, può succedere qualcosa di miracoloso: in quella presenza, l’altro non si sente più solo.
E noi, a nostra volta, ci sentiamo più umani.
Ecco perché la compassione non è solo un valore spirituale.
È una pratica quotidiana. Un modo di stare nel mondo.
Con i colleghi. Con gli amici. Con i clienti. Con gli sconosciuti.
Con noi stessi, soprattutto.
Perché spesso siamo duri, esigenti, impazienti… proprio con la persona che dovremmo trattare con più amore: noi.
Compassione non è debolezza. È forza che accoglie.
È il contrario dell’indifferenza.
È il coraggio di stare.
È il ponte invisibile che ci unisce, anche quando tutto intorno ci spinge a dividerci.
E in un’epoca che grida, che corre, che consuma tutto, anche le emozioni… avere compassione è il gesto più silenzioso, ma anche più rivoluzionario, che possiamo fare.
Di tutto questo e qualcos’altro ne ho parlato nella puntata del podcast We are the Net
La Magia della Compassione